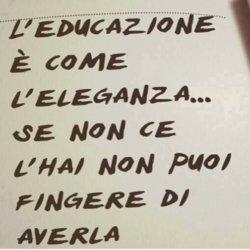 Brontoliamo di continuo. I giovani non sono educati, stanno male a tavola, non salutano, sono scomposti, non si alzano in piedi quando entriamo in una stanza, non sanno dare del lei.
Brontoliamo di continuo. I giovani non sono educati, stanno male a tavola, non salutano, sono scomposti, non si alzano in piedi quando entriamo in una stanza, non sanno dare del lei.
Educazione vuol dire, però, molto di più di alcune formali regole di comportamento. Sì, lo so, sono la prima a dire che è facile, sull’onda di un entusiasmo affettivo, passare sopra al fatto di chi sta molto male a tavola, gesticola col coltello, china la testa sul piatto, mugugna, invece di salutare, fa cenni di fastidio mentre abbiamo cose importanti da riferire, tratta male il benzinaio, butta la biancheria da lavare per terra, non sciacqua la vasca, non leva il dentifricio caduto nel lavandino, si soffia il naso con fracasso, starnutisce senza proteggere la bocca, parla a bocca piena etc. etc.
All’infinito, o quasi, il numero delle norme da seguire, che si moltiplicano se si tiene conto che variano di paese in paese: tutti ci ricordiamo l’educato (per loro) ruttino di felice apprezzamento del cibo degli asiatici. Ma molti anni dopo aver ritenuto non essenziali alcune regole di comportamento, passato o intiepidito il sentire, resterà un brutto e criticabile comportamento con cui dovremo convivere quotidianamente.
 Un brutto spettacolo che non ci darà requie: ci infastidirà, ci disturberà, ci farà venire i nervi; sbufferemo, ma… colpa nostra. Avremmo dovuto intervenire in tempi di entusiasmo quando le nostre critiche affettuose avrebbero avuto un ben maggiore peso sui nostri affetti famigliari o acquisiti.
Un brutto spettacolo che non ci darà requie: ci infastidirà, ci disturberà, ci farà venire i nervi; sbufferemo, ma… colpa nostra. Avremmo dovuto intervenire in tempi di entusiasmo quando le nostre critiche affettuose avrebbero avuto un ben maggiore peso sui nostri affetti famigliari o acquisiti.
L’educazione, o almeno quello che noi ancora chiamiamo tale, non è solo un invito alla compostezza, al non disturbo della vita altrui, invitandoci a non parlare ad alta voce al cinema, a cedere il passo per attraversare una porta (norma di educazione ma anche di necessità per non spiaccicarci nel tentativo di entrare con urgenza in due in uno spazio ristretto) o altro.
 Educare (da e-ducere) vorrebbe anche significare il trarre fuori da ognuno di noi il meglio per affrontare una convivenza civile. Per cui, soprattutto, rispetto per le persone che ci circondano, in modo da poter vivere una vita affollata senza infastidirsi troppo a vicenda, ma, anche, abituarci alla competizione pur accettando di buon grado le sconfitte (mamma mia, quanto era difficile perdere senza abbandonarsi a mostruosi capricci), essere leali, generosi (terribile quando i genitori ci spingevano a cedere il nostro primo premio al secondo arrivato e pure con un sorriso).
Educare (da e-ducere) vorrebbe anche significare il trarre fuori da ognuno di noi il meglio per affrontare una convivenza civile. Per cui, soprattutto, rispetto per le persone che ci circondano, in modo da poter vivere una vita affollata senza infastidirsi troppo a vicenda, ma, anche, abituarci alla competizione pur accettando di buon grado le sconfitte (mamma mia, quanto era difficile perdere senza abbandonarsi a mostruosi capricci), essere leali, generosi (terribile quando i genitori ci spingevano a cedere il nostro primo premio al secondo arrivato e pure con un sorriso).
Educati a non cedere alla prima sconfitta, educati a lottare ma con armi proprie, educati a stringere i denti ed andare avanti.
Di fatto.
Nella nostra infanzia eravamo perennemente feriti, graffiati, ginocchia sbucciate. Eravamo forse più spericolati dei bambini di oggi. Nascondevamo con cura le nostre ferite nel timore di avere conseguenti privazioni di libertà ma, una volta inesorabilmente scoperti, ecco che compariva il nemico: l’ALCOL. Non l’acqua ossigenata, che non bruciava, ma l’ALCOL. Messo sulle ferite con una piccola garza, senza pietà. Immancabile l’avviso “brucerà”. E in effetti bruciava da pazzi, inutile soffiare per attutire il dolore e, oltre tutto, le ferite a volte erano localizzate dove il soffio generoso non arrivava.
Non erano nulla le profonde sbucciature, i tagli per le cadute dalle biciclette era l’alcol il nemico. E a tutto ciò si aggiungeva che era vietato fare la lagna, lamentarsi, piangere: bisognava stringere le labbra e sopportare. Anche questo era, a quel tempo, educazione. Soffrire(e possibilmente soffiare) ma in silenzio.
Mi trovavo giorni fa a trovare una mia amica in ospedale. La stanza condivisa da una altra signora della stessa età che aveva affrontato un identico intervento.
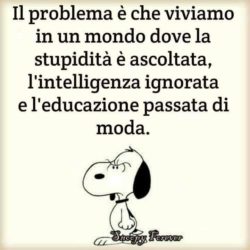 Dal letto della sconosciuta una sceneggiata alla De Filippo: “GGIESU’, GGIESU’ cche mmale. Non ce la faccio più. Che dolore! Mamma mia! Chiamate il dottore, non è possibile. Dove sono le infermiere? Perché non c’è nessuno? Datemi una pillola! Portatemi via. Qua mmuoio”.
Dal letto della sconosciuta una sceneggiata alla De Filippo: “GGIESU’, GGIESU’ cche mmale. Non ce la faccio più. Che dolore! Mamma mia! Chiamate il dottore, non è possibile. Dove sono le infermiere? Perché non c’è nessuno? Datemi una pillola! Portatemi via. Qua mmuoio”.
A nulla servivano le esortazioni dei parenti accorsi che cercavano di tranquillizzarla dicendole che anche la cognata Mariuccia aveva subito la stessa sorte e non aveva sofferto tanto (il che voleva dire che non aveva alzato tutto quel putiferio). “Ma il male mio è mille volte più grande, solo io so cosa soffro”, e giù invocazioni strillate a tutti i Santi del cielo.
Le infermiere andavano e venivano esauste con gli occhi al cielo per il campanello che non smetteva un minuto di chiamarle. L’intero reparto ruotava intorno alla terribile paziente impaziente. Unica al mondo a soffrire, unica non seguita con abbastanza cura, unica destinata a  morire di fame per la terribile qualità del cibo dell’ospedale. Unico momento di requie dalle lamentele senza fine quello in cui la parente estrae da un enorme canovaccio le lasagne portate da casa. Il dolore si è attutito? Forse! A giudicare da come si avventa sul suo pranzo. Troppo poco ahimè. Appena divorata avidamente l’ultima forchettata, riprende a strepitare senza posa .E di nuovo “GGIESU’ GGIESU’ ccche mmale”.
morire di fame per la terribile qualità del cibo dell’ospedale. Unico momento di requie dalle lamentele senza fine quello in cui la parente estrae da un enorme canovaccio le lasagne portate da casa. Il dolore si è attutito? Forse! A giudicare da come si avventa sul suo pranzo. Troppo poco ahimè. Appena divorata avidamente l’ultima forchettata, riprende a strepitare senza posa .E di nuovo “GGIESU’ GGIESU’ ccche mmale”.
La mia amica accanto sta tranquilla in silenzio. Il caos creato dalla sua vicina lo respinge stando ad occhi chiusi. Ogni tanto le sfugge una smorfia di dolore che subito ricaccia. Alle mie domande risponde che sì certo fa un po’ male, sì certo la notte ha un po’ sofferto, sì non riesce tanto a dormire ma dopo tutto è sempre stato un intervento che ha subito, e non è pensabile che non si soffra. Le infermiere sono gentili. Non farebbe la coda per il vitto dell’ospedale ma, magari, per qualche giorno, farà anche bene alla salute.
mie domande risponde che sì certo fa un po’ male, sì certo la notte ha un po’ sofferto, sì non riesce tanto a dormire ma dopo tutto è sempre stato un intervento che ha subito, e non è pensabile che non si soffra. Le infermiere sono gentili. Non farebbe la coda per il vitto dell’ospedale ma, magari, per qualche giorno, farà anche bene alla salute.
La soglia del dolore, lo sappiamo, ha diversi gradi per ognuno di noi ma nella differenza di comportamento nell’affrontarlo non avrà il suo peso anche almeno in parte una diversa educazione?


E proprio cosi! Voto10, da brava figlia di ammiraglio. Sei sempre spiritosa.